
Salvator Rosa: pittore maledetto tra stregoneria e negromanzia
La strega

Salvator Rosa, La strega, 1647-1650 circa, olio su tela, 212 x 147 cm, Gallerie degli Uffizi, Firenze.
Salvator Rosa (Napoli, 22 luglio 1615 – Roma, 15 marzo 1673) fu artista e poeta, tra i più interessanti esponenti dell’età barocca, attivo non solo a Napoli, ma anche a Roma e Firenze. Proprio a Firenze, ricevette ospitalità da Giovan Carlo de' Medici, signore con spiccate velleità culturali, che fece costruire il teatro alla Pergola, inaugurato nel 1657 e fu protettore delle Accademie degli Instancabili, degli Improvvisi e dei Percossi. Quest'ultima accademia, in particolare, fu fondata proprio da Rosa, che amava organizzare cene in cui recitare satire e commedie con largo impiego dell'improvvisazione. Grazie all'Accademia dei Percossi, Rosa ebbe modo di stringere amicizia e frequentare personaggi legati al mondo letterario fiorentino; fra questi si segnalano il commediografo Giovan Battista Ricciardi e il ricco borghese Carlo Gerini, che possedeva diverse sue opere: la Fortuna, la Selva dei Filosofi, Cratete che si disfa del suo denaro disperdendolo in mare, Battaglia con il turco e Tizio. A Firenze fu anche autore de le Satire in terzine, in cui si mostrò favorevole ad una pittura di ispirazione letteraria e filosofica e conobbe Lucrezia, la donna che starà al suo fianco per tutta la vita.
A questo decisivo periodo fiorentino, fanno riferimento alcune opere del pittore caratterizzate da soggetti magici ed esoterici. La Strega è il capolavoro assoluto del tormentato e originale pittore seicentesco Salvator Rosa, recentemente entrata a far parte della collezione degli Uffizi. Al centro dell’imponente dipinto, la figura è inginocchiata: il suo corpo sgraziato, cadente con accentuati segni del tempo e mescolando i tratti femminili con caratteristiche più androgine. Il viso è stravolto: la vecchia sbarra gli occhi pieni di rabbia, impreca e brandisce un ramo in fiamme nella mano sinistra, ostentando nell’altra un contenitore di forma sferica dal quale spunta una figura diabolica, simbolo delle forze infernali evocate con i suoi malefici. Sparsi in terra, vari oggetti, ciascuno dei quali ha un oscuro significato nel contesto del macabro
evento: una brocca di vetro, delle monete, uno specchio, pezzi di ossa, un teschio e, in primo piano, squillante sul fondo bruno, un foglio bianco recante simboli esoterici insieme all’inconfondibile monogramma dell’autore: “SR”. Il dettaglio più sinistro e raccapricciante della composizione è però il bambino avvolto in un panno, nella penombra in secondo piano, alle spalle della fattucchiera. Si tratta di un bimbo morto, in riferimento alla leggenda secondo la quale le streghe utilizzavano il sangue infantile per preparare le loro pozioni magiche.
La frequentazione della corte medicea, dell’ambiente raffinatissimo delle accademie e degli eruditi fiorentini, fortemente interessati ai temi esoterici, filosofici, ermetici e applicati allo studio dei testi filosofici antichi come il Corpus Hermeticum, giunto a Firenze fin dalla seconda metà del XV secolo, tradotto da Marsilio Ficino e pubblicato in prima stampa nel 1470, contribuirono in modo decisivo a orientare le scelte di Rosa verso le rappresentazioni di carattere negromantico di questo periodo. Oltre a La Strega, si segnala anche le Streghe e gli incantesimi, oggi alla National Gallery di Londra. Con questo dipinto, la Strega condivide la pittura densa e macchiata e l’insistenza sul dettaglio grottesco, forzato fino all’inverosimile e alla deformazione. Nella scelta iconografica, Rosa richiama la tradizione dei pittori nordici di Cinque e Seicento, da Dürer a Baldung Grien a Jacques de Gheyn. Al tema della magia il pittore dedicò poi anche alcuni componimenti letterari, tra i quali un’ode intitolata proprio La Strega (1646), incentrata sul tema della maledizione lanciata da una strega contro un uomo che non ha ricambiato il suo amore, testo che peraltro contiene non pochi elementi in comune con il dipinto appena comprato dal museo fiorentino.
Il Sabba delle streghe

Salvator Rosa, Le Streghe e gli Incantesimi, 1646 circa, olio su tela, 72 × 132 cm, National Gallery, Londra.
Il dipinto oggi alla National Gallery fu probabilmente realizzato per il banchiere e collezionista fiorentino Carlo Rossi intorno al 1646. In un’atmosfera buia e spaventosa, vengono orchestrati incantesimi bizzarri e terrificanti. Figure mostruose, alcune delle quali nude, sono disposte in maniera teatrale, come su un palcoscenico, illuminate da fonti di luce sparse. La macabra scena allestita da Rosa evoca un sabba delle streghe, ovvero un raduno in cui si adora il diavolo. Al centro di questa immagine spettrale, una strega affumica il cadavere di un criminale appeso a un albero appassito, mentre una figura incappucciata gli taglia le unghie dei piedi. Seduta di fronte a loro su un blocco di pietra, un'altra strega regge uno specchio e gioca con una piccola effigie di cera. Un catalogo di aiuti magici circonda la figura nuda accasciata a terra che spreme sangue da uno straccio, o forse da un organo umano, e lo versa in un calderone. Vicino, un uomo in armatura si china su una lepre bianca che brucia all'interno di un cerchio magico. È accompagnato da altri due uomini: uno regge una scopa, l'altro ha una spada su cui è infilzato un cuore umano.
A sinistra, due figure macabre riesumano uno scheletro e lo costringono a firmare un documento: si tratta di una forma di negromanzia, la pratica di comunicare con i morti. Alle loro spalle, una figura velata con una ghirlanda esegue una cerimonia misteriosa. Sulla destra, creature demoniache emergono dall'ombra. Una gigantesca bestia anfibia con fauci spalancate e ossa al posto delle braccia è cavalcata da una donna con un turbante giallo, mentre un uccello scheletrico con un becco affilato incombe sul bambino in fasce tenuto in alto da una strega urlante. Sembra che stia per sacrificare il bambino al mostro sottostante. All’epoca i processi per stregoneria erano numerosi. Appare ormai chiaro come a Firenze, il pittore sviluppò un avido interesse per il soprannaturale e divenne parte di un gruppo di intellettuali, attori, scienziati e artisti che condividevano il fascino per l'occulto. Rosa divenne anche intimo amico del poeta e pittore fiorentino Lorenzo Lippi, che incoraggiò il suo amore per il macabro. Entrambi si ispirarono alle stampe di artisti del Nord come Hans Baldung e Albrecht Dürer, che esplorarono anche i temi della stregoneria.
In copertina: Salvator Rosa, Teschio urlante, 1640-1645 circa, olio su tela, cm 24 x 19.3.
Suggeriti

ARTE ESOTERICA TRA FINE OTTOCENTO E PRIMI DEL NOVECENTO

PSEUDO CAROSELLI: IDENTITÀ MISTERIOSA E SOGGETTI MAGICI

LA STREGHE DI ALBRECHT DÜRER

IL MALLEUS MALEFICARUM E L'OPERA DI VIRGINIE REBETEZ
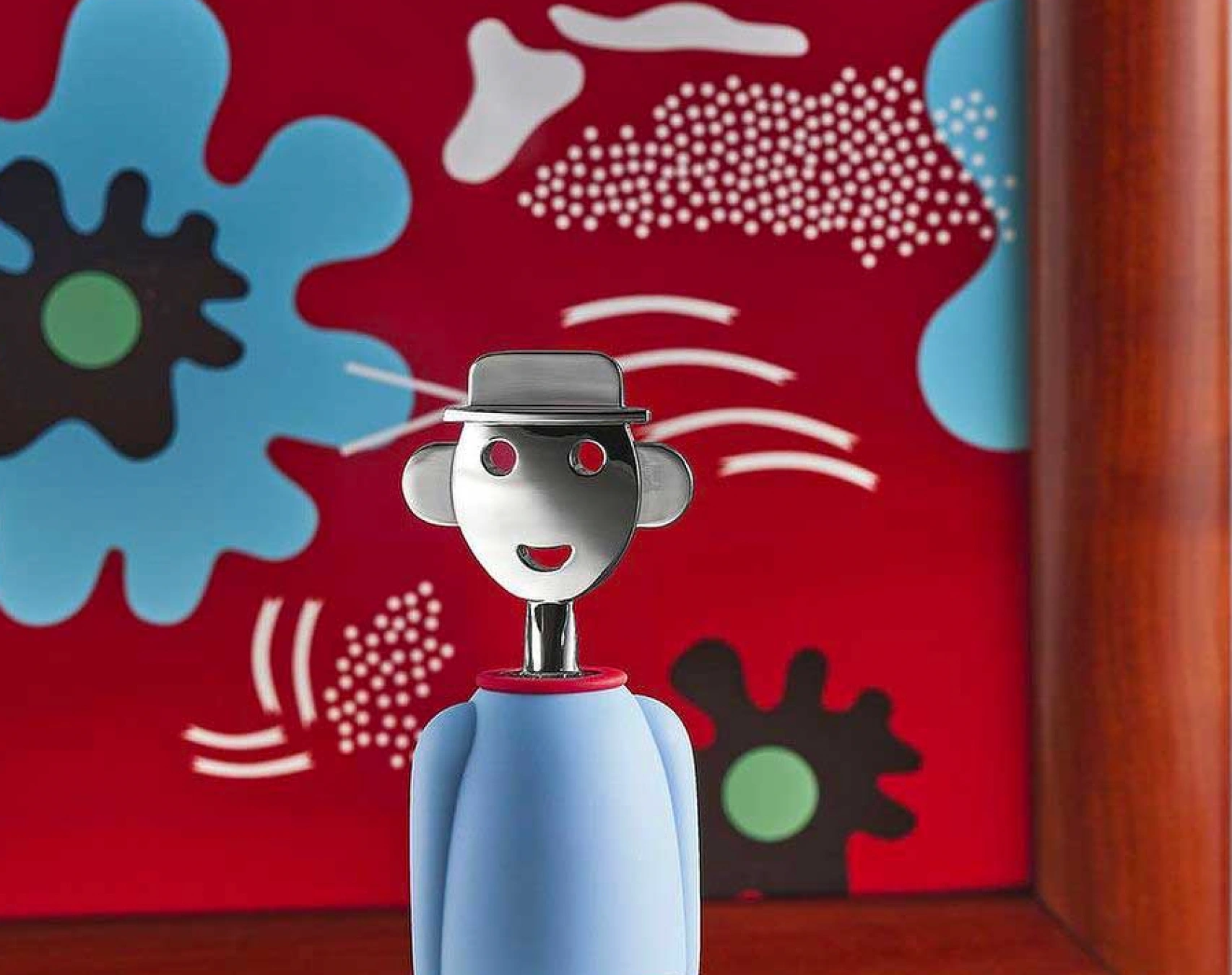
ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

CARLO SCARPA A PALERMO: L'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DI PALAZZO ABATELLIS
