
La moda made in Italy e l'architettura brutalista si incontrano: Bottega Veneta e la Casa Albero
Bottega Veneta e la Casa Albero

Uno degli scatti della campagna fotografica di Bottega Veneta per la collezione AW23.
Per la campagna autunno inverno 2023 Bottega Veneta scelse la cornice della Casa Albero, anche nota come Casa Sperimentale, situata nella pineta di Fregene, a 30km da Roma, esempio interessantissimo di architettura brutalista. La campagna, la terza sotto la direzione di Matthieu Blazy, fu scattata da Louise Thornfeldt, Maria Thornfeldt, Malick Bodian e Sander Muylaert e dialoga perfettamente con lo sfondo architettonico di Giuseppe Perugini, Uga De Plaisant e Raynaldo Perugini - padre, madre e figlio che l'hanno costruita tra il 1968 e il 1975 proprio per viverla come casa vacanze di famiglia. La località di Fregene negli anni '60 stava vivendo, come tutta la penisola, un intenso boom economico e osservava un periodo di forte vitalità edilizia, con la costruzione di numerose case estive. In questa cornice, Giuseppe Perugini compra un terreno insieme a sua moglie per concretizzare la sua idea di tenuta feriale.
L’identità unica dell’edificio e la sua italianità la rendono l’abbinamento perfetto con Bottega Veneta, un brand radicale, forme pulite e aura eterna.
Anche se a prima vista infatti, il mondo dell’alta moda e l’architettura sperimentale sembrino appartenere a universi distanti, esistono eppure affinità sorprendenti tra l’estetica di Bottega Veneta e la Casa Albero di Fregene, opera visionaria dell’architetto Perugini. Entrambi i linguaggi – quello sartoriale del brand e quello architettonico dell’abitazione – condividono un rapporto profondo con la materia, la natura e il gesto artigianale. Uno degli elementi più evidenti che li accomuna è il tema dell’intreccio. Nella Maison Bottega Veneta, l’intrecciato in pelle è molto più di una tecnica: è una firma stilistica che racconta manualità, attenzione al dettaglio e continuità tra tradizione e innovazione. Nella Casa Albero, l’intreccio si manifesta in una forma più astratta ma altrettanto potente: è presente nella modularità degli spazi, nella connessione fluida tra interno ed esterno, e nel dialogo tra materiali diversi – cemento, vetro, acciaio – che si intrecciano per generare un organismo architettonico in simbiosi con l’ambiente circostante. Entrambe le opere instaurano un rapporto profondo con la natura, non come semplice sfondo, ma come parte integrante dell’esperienza estetica. La Casa Albero è letteralmente sospesa tra gli alberi di Fregene, come un organismo che cresce e respira insieme al paesaggio, mentre Bottega Veneta esplora un’estetica della naturalezza materica, privilegiando lavorazioni che esaltano la qualità intrinseca dei materiali, senza eccessi decorativi.
Infine, tanto la Casa Albero quanto il design di Bottega Veneta rifuggono la spettacolarizzazione fine a sé stessa. Entrambi propongono un minimalismo colto e sofisticato, dove la complessità nasce da un uso sapiente delle forme, dei volumi e delle superfici, mai ostentati ma sempre funzionali e ricchi di significato.
In questo dialogo silenzioso tra moda e architettura, si riconosce una comune tensione poetica: quella di un lusso che non urla, ma sussurra, che non segue le mode, ma costruisce nel tempo un’identità forte e inconfondibile.
Il padre della Casa Albero
La campagna pubblicitaria di Bottega Veneta fu l'occasione per il mondo, di recuperare la brillante figura di Giuseppe Perugini (Buenos Aires, 17 marzo 1914 – Roma, 19 settembre 1995): un architetto di nascita argentina, arrivato a Roma nei primi anni Trenta, che diede un fondamentale contributo all'architettura romana e italiana del Novecento. Appena arrivato nella capitale frequenta Adalberto Libera, tra i maggiori esponenti del razionalismo, e si laurea nel 1941 alla Sapienza, dove poco dopo diviene docente di composizione architettonica. Dopo la guerra, inizia subito una intensa attività didattica e professionale, partecipando alle iniziative promosse dal Ministero dei lavori pubblici per la formulazione di una normativa destinata a uniformare i processi di ricostruzione postbellica del Paese; è stato componente di varie commissioni, tra cui quella dell'Istituto Superiore per l'Edilizia Sociale (ISES), per il recupero delle zone terremotate del Belice, la Consulta dei Ministero della Pubblica Istruzione per le normative sull'edilizia scolastica, la commissione edilizia e della commissione per lo studio dei nuovo assetto urbanistico dell'area metropolitana di Roma. Fondatore dell'Associazione per l'Architettura organica, dal 1962 al 1966 è stato presidente dell'Ordine degli architetti di Roma e Lazio e presidente dell'Opera Universitaria. Per Perugini la composizione architettonica era da preferire e difendere sopra ogni ragionamento formale, la sperimentazione andava anteposta a ogni tipo di conoscenza acquisita e l’innovazione fu il motore principale di una metamorfosi che permette a ciò che viene creato dall'uomo, quindi al mondo artificiale e costruito, di aderire alla realtà. L'architetto era un romantico sognatore, un filosofo dell'architettura a cui non mancavano però due caratteristiche fondamentali per questa scienza: concretezza e determinazione.
Perugini fu convinto sostenitore del concorso di progettazione come strumento di qualità architettonica, la cui professionalità ha ambito alla commistione di innovazione tecnologica e poesia dell’architettura. Arrivato in Italia molto giovane per divenire scultore, si dedicò all’architettura grazie alla complicità di un infortunio al braccio mal risolto che limitò la mobilità dell’arto, permettendogli comunque di disegnare e dipingere ad alti livelli. Di quella passione giovanile abbandonata per motivi di salute, resta un forte senso plastico trasferito nei suoi interventi architettonici anche a scala urbana.
“Nelle sue opere traspare, oltre l’aspetto di innovazione tecnologica e sperimentazione, anche quello di una architettura quasi scultorea dove gli spazi, anche grazie all’uso sapiente della luce, vengono modellati attraverso la scomposizione delle parti e ricomposti in una ordinata sequenza spaziale dell’organismo architettonico”, osservava Giuseppe Parisio.
Visse gli anni Trenta immerso nelle Avanguardie, frequentando il secondo futurismo e assorbendo le tendenze razionaliste, tanto da stringere importanti amicizie con artisti, professori ed intellettuali del calibro di Guttuso, Libera, Cagli, Sapegno con cui studiò architettura all'Università, Del Debbio, Professore di cui fu assistente, Sacripanti, Zevi, Pellegrini, Sartogo, Passarelli.
Insieme ad Uga de Plaisant, una donna di antica nobiltà francese conosciuta all’università, forma un sodalizio privato e professionale, che molto ha donato alla storia dell’architettura: due anime architettoniche che hanno affidato al dialogo e al confronto continui la tensione progettuale.
“Recente la ricerca Tecniche Sapienti, finanziata con fondi de La Sapienza e coordinata da Claudia Mattogno, che si è proposta di indagare e riscoprire le figure di donne che ne hanno attraversato le aule e come studenti, assistenti o docenti e, nel trovare la loro strada, hanno contribuito ad animarne la vita scientifica – racconta Rosalia Vittorini, Professore associato, Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Università di Roma Tor Vergata – Tra queste Uga de Plaisant che con coraggio e risolutezza ha condiviso una democrazia dell’architettura in casa, grazie al continuo confronto con il marito Giuseppe prima e poi anche con il figlio Raynaldo. Fa parte di quelle pioniere a cui la comunità scientifica e la società tutta non hanno mai reso il giusto merito per questioni di genere”. La collaborazione tra Perugini e la de Plaisant inaugura un nuovo metodo di composizione architettonica: l’architettura viene ripensata alla luce del mondo attuale, in cui i vecchi modelli sono inapplicabili. Un percorso che dà vita a costruzioni sperimentali, seppur sempre e comunque concretamente realizzabili.
Interessante il suo rapporto con la storia e la storia dell'architettura, base intrinseca di alcuni lavori da progettista, previa profonda interiorizzazione e rielaborazione.
Nel progetto delle Fosse Ardeatine la lastra è leggermente inclinata per correggere l’aberrazione ottica ed è bombata e incavata dentro per evitare un senso di schiacciamento. Inoltre la costruzione è sospesa in sei punti per lasciare un taglio di luce che la fa galleggiare come Santa Sofia a Costantinopoli. “Involontariamente ha inclinazione analoga a quella del Partenone – osserva il figlio Raynaldo – Era un grande conoscitore della storia dell’architettura che indagava con disegni molto espressivi. La storia è grammatica, ovvero tutto quello che è classico, proporzioni, rapporto aureo, mentre i vocaboli sono gli stili. E lui maneggiava questo lessico con estrema abilità”. Così nei palazzi di giustizia di Piazzale Clodio richiama la strada attraverso camminamenti in sampietrini a ricordare che nell’antica Roma la giustizia era nel Foro e che il suo carattere deve essere concreto.
Tra le sue opere più immaginifiche il ponte circolare sullo Stretto di Messina (1969) la cui forma ben si adatta alla resistenza ai venti ed ai sismi, le torri ad elica con sale girevoli del concorso per Plateau Beaubourg a Parigi (1971) e l’ospedale cibernetico di Pietralata (1967) a Roma con moduli in movimento attorno al paziente.
L'opera più interessante però, anche perché in collaborazione con Uga de Plaisant e il figlio Raynaldo, resta la casa di Fregene, volutamente incompiuta, nella sua estrema plasticità sottolineata dal cemento a facciavista in contrasto col rosso vivo degli infissi, mostra la possibilità di vivere in un modo diverso dal tradizionale, nonostante i limiti di un tentativo abitativo. Senza pareti né destinazioni specifiche, può crescere all’infinito. Nelle parole di Marco Maria Sambo, Segretario OAR, Direttore AR Magazine “Non è solo una ricerca formalista, ma è una sperimentazione sulle nuove e possibili caratteristiche dell’abitare, in mezzo alla natura. Quindi rappresenta una ricerca organica di habitat, alla piccola scala. Perugini, in alcune sue opere, riesce a prefigurare nuovi habitat, nuove prospettive, nuovi scenari”.
L'alieno brutalista di Fregene

La Casa Albero di Fregene nello scatto di Andy Tye, French+Tye.
Oggi emblema indiscusso dell’architettura costruttivista, la dimora colpisce immediatamente per l’alta componente di calcestruzzo grezzo e a vista impiegato e per il contrasto con le architetture circostanti, decisamente più tradizionali. Si distingue per la sua pianta e conformazione unica: la Casa, pensata con una struttura aperta ed infinitamente modulare, è realizzata in calcestruzzo grezzo, vetro e acciaio. La Palla è uno degli ambienti più peculiari della struttura: si tratta di una sfera di 5 metri di diametro concepita come appendice esterna, è a sua volta un esempio di struttura abitativa, forma perfetta e simbolo della compiutezza e della perfezione cosmica, attrezzata come una casa indipendente. I Cubetti, posti su diversi piani, sono idealmente ampliabili in maniera infinita secondo un concetto di modularità e ripetizione. Qui si snodavano gli ambienti della camera da letto, del soggiorno, della cucina e i bagni.
La casa sembra sospesa tra gli alberi anche se in realtà è sorretta da grandi piloni di cemento, che insieme al vetro e al metallo sono gli unici materiali utilizzati per la costruzione. La scala che porta all’ingresso, dipinta di rosso acceso, può essere alzata in modo da isolare gli inquilini dal mondo esterno; l’unico elemento che tocca il terreno, invece, è una capsula rotonda che può essere utilizzata come stanza per gli ospiti. Dopo la scomparsa dell’architetto Perugini, cui è seguita quella di sua moglie, la Casa è stata frequentata sempre meno da parte della famiglia, l’edificio ha iniziato a subire il passare del tempo, l’incuria e agli atti di vandalismo ne hanno danneggiano interni ed esterni.
Un nuovo modo di abitare
Tralasciando la necessità più diretta che ha portato alla concezione di questa architettura, ovvero il desiderio di Perugini e della sua famiglia di trascorrere le vacanze in maniera stimolante, lo scopo della Casa Albero è esplorare nuovi modi di intendere i concetti di abitare. Con questo progetto l'architetto infatti sovverte le tradizionali concezioni ortodosse e diffuse riguardo le più classiche tipologie edilizie, non più allineate alle esigenze abitative della società contemporanea. Una nuova società necessita di un nuove forme dell'abitare, e la Casa Sperimentale vuole essere l’avamposto per questa esplorazione a carattere architettonico-sociale, il cui principio fondamentale è la totale libertà da ogni genere di costrizione.
La Casa Albero ha ispirato e continua a ispirare generazioni e mondi diversi

Frame del video della Dark Polo Gang per la canzone Dark Boy (Prod. by Sick Luke & Nino B), per la regia di Tommy Antonini.
Non solo moda: la Casa Albero di Fregene con le sue forme così peculiari e uniche ha ispirato anche il mondo della musica. Nel 2016, fu infatti anche scelta come ambientazione per il videoclip di Dark Boy del gruppo trap romano Dark Polo Gang. Testimonianza di come l'architettura visionaria e curiosa di Perugini abbia colpito profondamente l'immaginario collettivo contemporaneo, attecchendo nell'alta moda, quanto nelle espressioni musicali più recenti. Ma quale è il suo stato oggi? Dopo un periodo di frequentazioni sempre più sporadiche da parte della famiglia Perugini e, successivamente, la morte di Giuseppe Perugini nel 1995, l’edificio è andato incontro a un lento processo di abbandono. L’azione costante del vandalismo ha ulteriormente accelerato il degrado della struttura. Nonostante ciò, Raynaldo Perugini si impegna ancora attivamente nella sua conservazione e nel tentativo di restauro. In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa del padre, ha anche organizzato visite guidate in collaborazione con Open House Roma, con l'intento di valorizzare e far riscoprire un'opera che continua a esercitare un forte richiamo. Sempre nel 2020, l’architetto Patrizio Bitelli ha fondato il Comitato Permanente per la Tutela della Casa Albero, con l'ambizioso proposito di trasformare la casa in uno spazio vivo, dedicato a mostre, eventi e iniziative culturali, sempre nel rispetto del suo valore architettonico e del suo stato di conservazione.
In copertina: la Casa Albero di Fregene di Giuseppe Perugini, Uga De Plaisant e Raynaldo Perugini.
Suggeriti
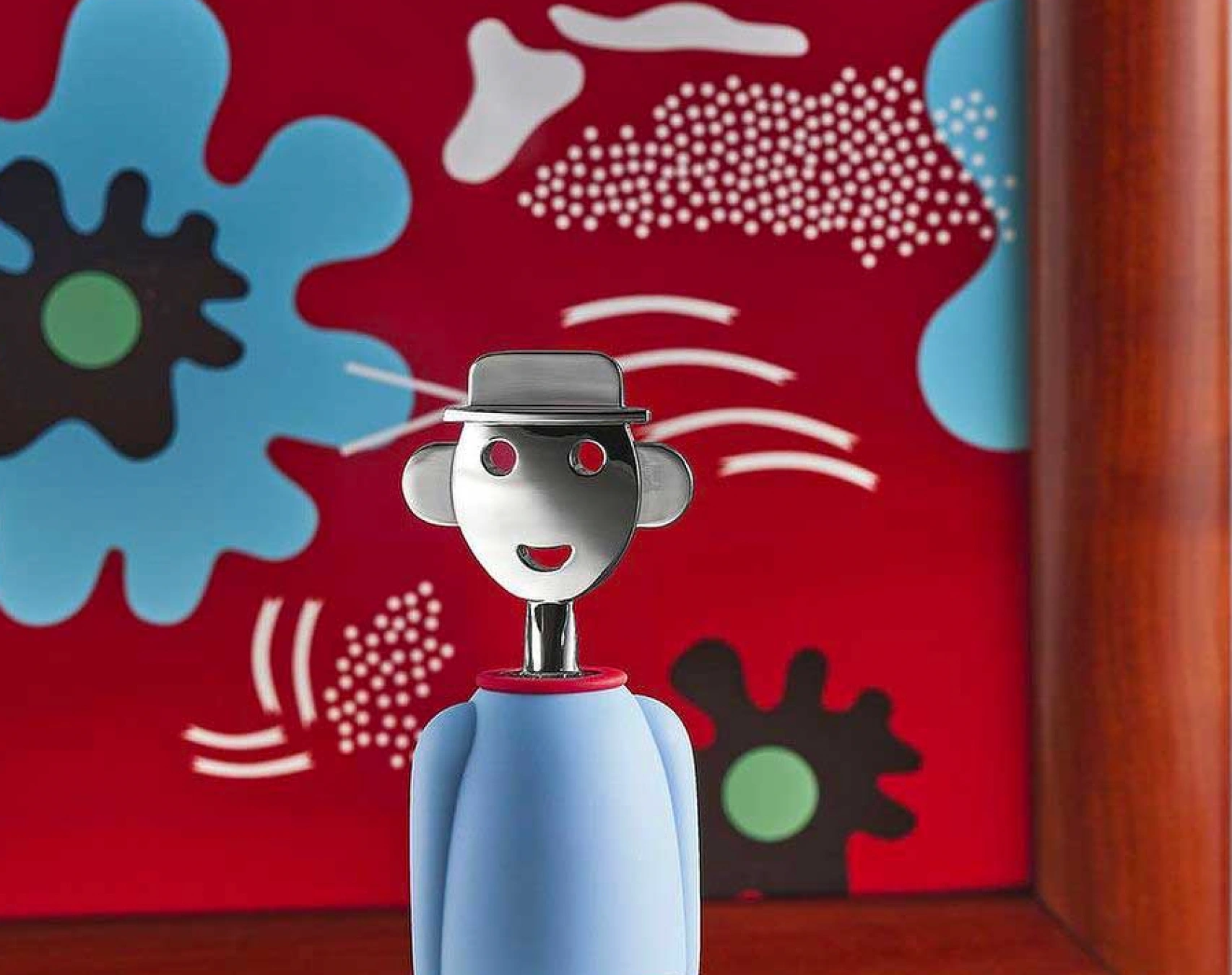
ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

ALVAR AALTO: DESIGNER E ARCHITETTO DEL LEGNO E DELLA LUCE

LEONARDO DA VINCI: IL GENIO CHE INVENTÒ IL DESIGN DEL FUTURO
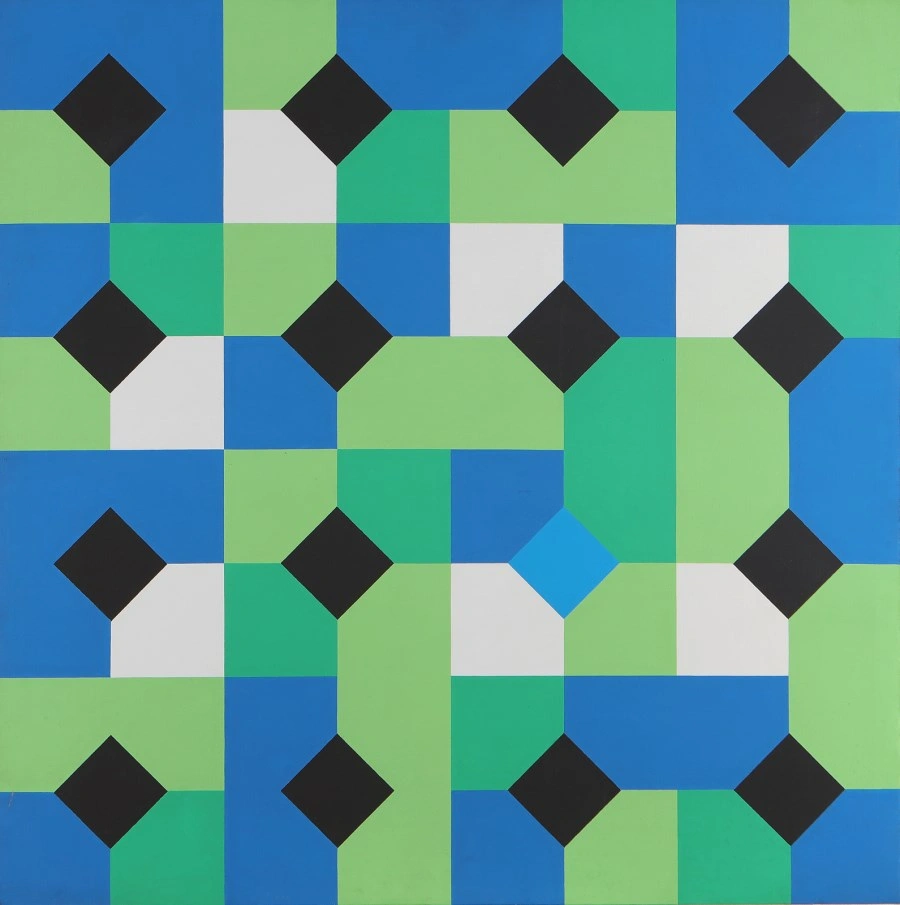
BRUNO MUNARI: PROGETTARE LA MERAVIGLIA

QUANDO LA MODA ITALIANA HA SCELTO COME SIMBOLO GLI ANGIOLETTI DI RAFFAELLO SANZIO

10 DIVANI CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL DESIGN
