
Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù di Dosso Dossi
Dosso Dossi: esponente di un Rinascimento eccentrico

Dosso Dossi, Pan e la Ninfa, 1524 circa, olio su tela, 163,83×145,42 cm, Getty Museum, Los Angeles.
Dosso Dossi, all'anagrafe Giovanni Francesco di Niccolò Luteri (San Giovanni del Dosso oppure Tramuschio, 1486 circa – Ferrara, 1542) è protagonista, in maniera del tutto personale ed eccentrica del primo Rinascimento. Un'artista stravagante, ma non così cerebrale da risultare criptico, alla maniera del Manierismo toscano, nonostante Vasari lo condanni proprio per il suo "troppo voler sforzare l’ingegno" forse ingelosito dal suo coinvolgimento, a scapito dell'aretino, nella committenza della Villa Imperiale di Pesaro, accanto al Bronzino. Il nome d'arte ha probabilmente una connessione con il supposto paese natale, San Giovanni del Dosso. I dati biografici noti su quest'artista sono scarsi e la data il luogo di nascita esatti sono ampiamente dibattuti dagli storici. Nella breve biografia compilata da Giorgio Vasari nel 1568, viene detto quasi contemporaneo di Ludovico Ariosto; tuttavia successivi studi di Carlo Giovannini collocano la nascita tra il 1486 e il giugno 1487. Si suppone inoltre che fosse figlio di Nicolò di Alberto di Costantino Luteri, economo presso la corte estense dei duchi di Ferrara, e di Jacopina da Porto. Originario del Trentino, Nicolò Luteri fu censito in un registro storico del 15 gennaio 1485 presso Tramuschio, dove divenne proprietario di un podere nella località allora nota come Dosso della Scaffa (l'attuale San Giovanni del Dosso) e di alcuni terreni della Fossa delle Pietre e di Villa Pentita in distretto di Mantova e vicariato di Quistello. Il fatto che Nicolò abbia battezzato i propri figli con i nomi di Giovanni e Battista potrebbe essere collegato al fatto che il santo patrono di San Giovanni del Dosso è appunto san Giovanni Battista. Peraltro, nel primo documento che attesta la presenza del pittore a Ferrara, egli venne chiamato Dosso della Mirandola. Il fratello, altro pittore attivo alla corte ferrarese, venne comunemente chiamato Battista Dossi (Battista del Dosso), sicché nel XVIII secolo gli storici locali, credendo che Dossi fosse il cognome, iniziarono a chiamare anche il fratello maggiore come Dosso Dossi, rimasto anche nella narrazione storica.
Cultura classica, Raffaello e Maestri veneti: i riferimenti artistici di Dosso Dossi

Dosso Dossi, decorazione pittorica del soffitto della Camera dei Semibusti, Villa Imperiale di Pesaro. Dettaglio con Francesco Maria della Rovere.
Il linguaggio visivo e artistico di Dosso Dossi si forma sulle opere di Giorgione. Allo stile del Maestro veneto, si affianca lo sguardo costante e profondo alla cultura classica e a Raffaello, oltre a una propria attitudine narrativa ben sviluppata. Nel 1510 si trovava a Mantova al servizio dei Gonzaga, e nel 1514 viene nominato pittore di corte a Ferrara. In tale veste fu coinvolto nelle principali imprese decorative di Alfonso d'Este, quali i Camerini d'alabastro. A lui è infatti attribuita la coreografia generale dell'apparato decorativo, a cui parteciparono da Venezia anche Giovanni Bellini e Tiziano, nonché la realizzazione di alcuni dipinti, tra cui il Trionfo di Bacco in India per il quale Raffaello aveva fornito i disegni senza però riuscire a dipingerlo per l'improvvisa scomparsa. A Dosso spettarono anche le tele che ornavano i soffitti e molte decorazioni minori. Come è noto il complesso dei Camerini venne smantellato con la devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio nel 1598 e i dipinti vennero dispersi. Quelli di Dosso finirono infine in parte alla Galleria Estense di Modena. Per questa città tra il 1518 e il 1521 realizzò una pala per l'altare di San Sebastiano nel duomo che gli era stata commissionata dalla Confraternita della Mensa Comune dei Preti.
Dosso Dossi, grazie a continui viaggi di formazione e studio, che lo vedono a Firenze, Roma e Venezia, Dosso si tenne sempre aggiornato alle ultime novità dei centri artistici nevralgici della penisola, avviando soprattutto un proficuo dialogo con Tiziano, da cui riprese la ricchezza cromatica e le ampie aperture paesaggistiche. Nonostante ciò nella sua arte non si registrano forti scarti stilistici tra le varie fasi, ma piuttosto l'uso di registri diversi a seconda del soggetto: monumentale per le pale d'altare, più fluido e ricco d'inventiva per i soggetti letterari e mitologici, che tuttora sono la parte della sua produzione più apprezzata dalla critica. Per un periodo fu in contatto con Michelangelo, dipingendo massicci nudi virili.
Verso il 1530, per i Della Rovere, affrescò la Villa Imperiale di Pesaro. Nel 1531 Il Principe Vescovo di Trento Bernardo Cles richiese ad Alfonso d'Este l'attività del Dosso, che per oltre un anno attese alla decorazione ad affresco di una ventina di ambienti del Castello del Buonconsiglio, dove lavorò a fianco del Romanino. Negli ultimi anni la produzione dell'artista si caratterizza per sempre maggiori contrasti chiaroscurali e rimandi simbolici. A questo proposito, addentriamoci in una delle opere più enigmatiche del pittore.
Un dipinto affascinante, che oggi sembra di difficile lettura

Dosso Dossi, Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù, 1523-1524 circa, olio su tela, 111,3 x 50 cm, Castello di Wawel, Cracovia.
L'opera è uno dei complessi dipinti allegorici ed esoterici che erano in voga a Ferrara nel primo Cinquecento, quando a corte erano ospitati letterati illustri tra i quali spiccava l'Ariosto. Lo spunto letterario è fornito dalVirtus di Leon Battista Alberti, cui viene data dall'ideatore della raffigurazione una nuova interpretazione in chiave onirica. Il dialogo dell'Alberti ha per protagonisti Mercurio, intento a difendere i momenti d'ozio di Giove da eventuali visitatori e disturbatori e la Dea Virtù, salita dai Campi Elisi all'Olimpo per lamentarsi della Fortuna. Mercurio dunque va verso la Virtù per ascoltarla, abbandonando momentaneamente Giove. Mercurio ritiene che le lamentele della Virtù siano pesanti e ingiustificate, ma quest'ultima la supplica affinché non diventi oggetto di derisione, essendo ormai già l'ultima tra le divinità. Giove nel mentre, è intento a dipingere farfalle e tutto il suo interesse è rivolto a questo compito apparentemente futile, di puro svago e relax. La vicenda dello scontro tra Virtù e Fortuna e le conseguenti lamentele di Virtù non lo interessano e tano meno, turbano minimamente. Dossi costruì un dipinto con tre figure principali legate da continui rimandi, in una struttura che ricorda l'arte veneziana ma più densa di simboli e messaggi reconditi, che mettono in secondo piano anche la bellezza delle figure o del paesaggio, qui ridotto a un accenno sintetico sullo sfondo di un cielo carico di nubi. A sinistra Giove, riconoscibile per la saetta appoggiata ai piedi, è ritratto nell'atto creativo, cioè mentre dipinge delle farfalle su una tela. L'animale è simbolo della volatilità del pensiero, così come anche l'arcobaleno che appare dietro il cavalletto è emblema dell'evanescenza delle idee. Col dipingere egli sottintende come al principio di ogni creazione sia necessario un'idea ispiratrice, legata a un concetto di ordine universale. La sua veste rossa, illuminata in maniera incidente, crea una forte macchia di colore, che si ricollega al drappo dello stesso colore su cui è seduto Mercurio, il secondo personaggio al centro. Anche i suoi attributi sono evidenti: il petaso e i calzari alati, nonché il caduceo dorato, che esprimeva il suo potere esoterico di addormentare e ridestare i viventi. Egli è il dio del Sonno e il suo gesto di invocare il silenzio è rivolto a frenare l'irruenza del terzo personaggio, la donna che si presenta alle soglie dell'Olimpo. Questa figura è rappresentata in atto supplice: la mano sinistra al petto e l'espressione intensa e speranzosa. Le radiografie dimostrano che in passato fosse addirittura inginocchiata. In accordo con il passo letterario, è stata frequentemente identificata con la Virtù, ma essa non ne possiede le caratteristiche iconografiche. La sua immagine corrisponde, secondo alcuni studiosi, piuttosto a quella dell'Aurora, come dimostrano i suoi attributi tipici: testa coronata di fiori, ghirlande di cui è agghindata, braccia nude, veste tripartita scossa dal vento. L’Aurora, secondo una tradizione che ricorre anche in Dante, è colei che, al suo apparire mattutino, disperde il sonno, e Mercurio le impedisce l'ingresso in Olimpo perché vuol proteggere il sonno di Giove. Questi dipinge ad occhi chiusi, e Dosso, seguendo l'analogia platonica tra sogno e pittura, allude al fatto che il signore degli dei sta sognando. Giove è ritratto con la fisionomia del duca Alfonso I, e il dipinto, destinato alla camera da letto del duca nel Castello del Belvedere, è un’allegorica difesa del sonno e del sogno, nel luogo riservato al riposo e agli svaghi del signore estense.
In copertina: Dosso Dossi, Giove pittore di farfalle, Mercurio e la Virtù, 1523-1524, olio su tela, 11, 3 x 150 cm, Castello di Wawel, Cracovia. Dettaglio.
Suggeriti
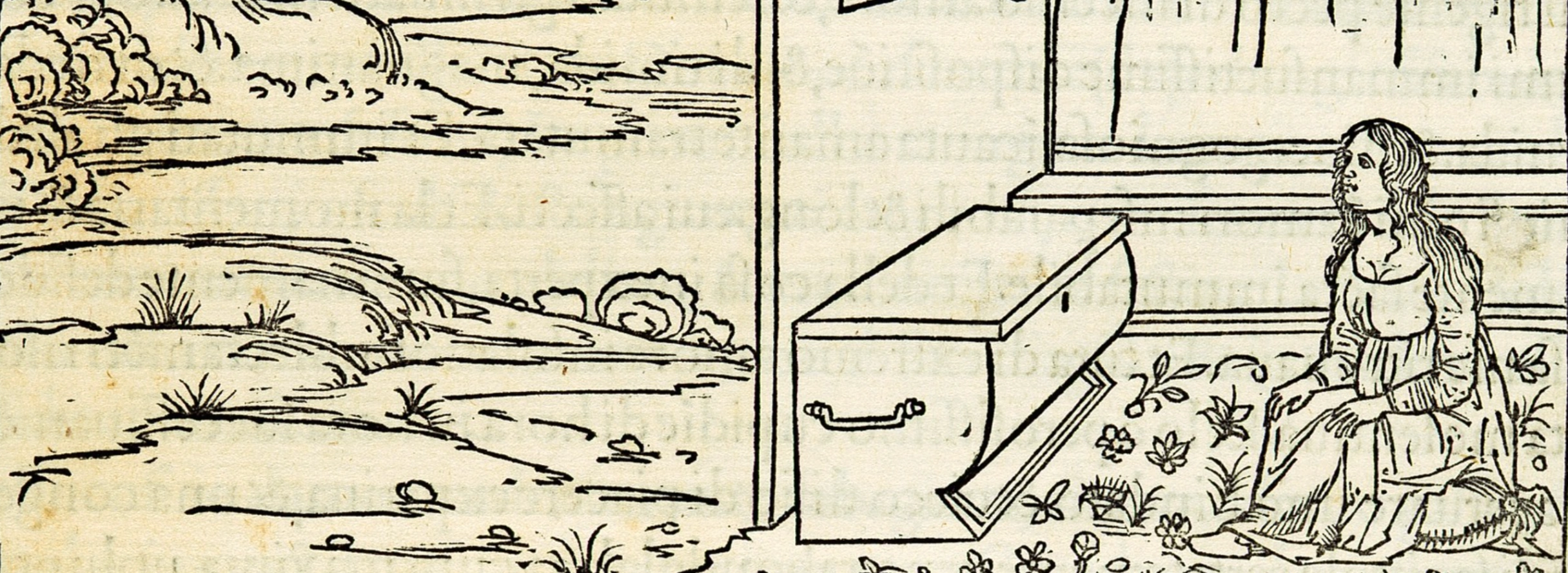
FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NATIVITÀ MISTICA DI SANDRO BOTTICELLI

LEONARDO DA VINCI: IL GENIO CHE INVENTÒ IL DESIGN DEL FUTURO

PIETRO TORRIGIANO: L'ACERRIMO RIVALE DI MICHELANGELO CHE CON LA SUA ARTE CONQUISTÒ INGHILTERRA E SPAGNA

QUANDO LA MODA ITALIANA HA SCELTO COME SIMBOLO GLI ANGIOLETTI DI RAFFAELLO SANZIO

BOTTICELLI INCONTRA BOCCACCIO: IL CASSONE DI NASTAGIO DEGLI ONESTI
