
Botticelli incontra Boccaccio: il cassone di Nastagio degli Onesti
Nastagio degli Onesti: l'amore non corrisposto, ma a lieto fine, nel Decameron di Boccaccio
Prima di analizzare la trasposizione pittorica dell'episodio letterario, conosciamo meglio le vicende di Nastagio degli Onesti, protagonista dell'ottava novella raccontata nella quinta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. La storia di Nastagio rientra nelle novelle d'amore a lieto fine: la figlia di Paolo Traversari, dopo aver rifiutato la corte di Nastagio, si ricrede assistendo alla punizione infernale di un'altra donna, che ha peccato di irriconoscenza verso l'amante. ll giovane Nastagio, proveniente dalla nobile famiglia degli Onesti di Ravenna, si innamora di una giovane, proveniente da una famiglia ancora più nobile, la quale, fiera della propria bellezza e nobiltà, rifiuta il suo amore. Preso dai sentimenti di un amore disperato, Nastagio pensa al suicidio, ma poi segue il consiglio di amici e parenti e, per dimenticare la donna, si allontana da Ravenna. Mentre si trova nella pineta di Classe, il giovane assiste ad una scena orrenda: una donna inseguita da tre mastini e da un cavaliere armato di spada, che la uccide e ne dà da mangiare il cuore e le interiora ai cani. Il corpo della donna si ricompone, lei riprende la fuga ed è nuovamente inseguita, uccisa dal cavaliere e data in pasto ai mastini. Nastagio vorrebbe aiutare la fanciulla, tuttavia il cavaliere gli intima di allontanarsi e gli spiega che quella scena si ripete ogni venerdì in quel luogo, in quanto egli, innamorato della donna senza essere corrisposto, si era ucciso, meritando la condanna all'inferno, mentre la donna, punita per aver gioito della sua morte, doveva scontare quella pena per tanti anni quanti erano stati i mesi della sua crudeltà verso di lui. Nastagio pensa allora di sfruttare la situazione a suo vantaggio e manda a chiamare i suoi parenti, ai quali chiede di invitare la famiglia Traversari ad un banchetto nella pineta per il venerdì successivo. Egli fa preparare un pranzo magnifico e fa mettere i tavoli sotto i pini intorno al posto dove aveva assistito allo scempio della donna. Al banchetto partecipa anche la figlia dei Traversari: al momento dell'ultima portata, tutti cominciano a sentire le urla disperate della donna e si ripete la macabra scena. La donna amata da Nastagio, vedendo ciò, decide immediatamente di concedergli il proprio amore e i due si sposano; la novella si conclude con l'affermazione che, a seguito di questa vicenda, tutte le donne di Ravenna si sono spaventate a tal punto da diventare molto più accondiscendenti ai desideri maschili nei loro confronti. Botticelli connota il racconto di Boccaccio con forte teatralità: la tensione drammatica convive con movenze statiche in uno stile assolutamente scenografico. Nei primi tre pannelli domina la narrazione attiva e pura (si susseguono la visione infernale, la caccia e il banchetto), mentre l’ultimo pannello — il vero e proprio banchetto nuziale — assume una forma compositiva più statica e architettonica, funzionale alla celebrazione simbolica del matrimoni. Un ciclo pittorico di rara bellezza e maestria compositiva, in grado di mixare alla perfezione contorni sinuosi, figure eleganti e allungate, contrasti cromatici netti tra vestiti saturi e paesaggi luminosi; spazialità e profondità in scene multiple contenute in una sequenza compatta, come in una narrazione teatrale.
Il dono di nozze di Lorenzo de'Medici per casa Pucci

Cassone nuziale del tardo Quattrocento, dipinto da Apollonio Giovanni di Tommaso, con la Battaglia di Trebisonda.
Sandro Botticelli fu chiamato da Lorenzo il Magnifico nel 1483 a dipingere quatto pannelli per il cassone nuziale da donare alla famiglia Pucci, in particolare a Giannozzo Pucci, in occasione del suo matrimonio con Lucrezia Bini. Già conservati a palazzo Pucci, nella seconda metà dell'Ottocento vennero disuniti: tre di essi oggi si trovano al Prado ed uno solo, l'ultimo, è ritornato nella sua collocazione originaria dopo essere stato, tra l'altro, nella Collezione Watney di Charlbury presso Londra.
I cassoni nuziali furono tra i più importanti oggetti d'arredo del Rinascimento italiano, in particolare tra il XIV e il XVI secolo. Si trattava di grandi cofani lignei riccamente decorati, commissionati in occasione di matrimoni aristocratici o borghesi. La loro funzione era sia pratica sia simbolica: servivano a contenere il corredo della sposa — biancheria, abiti, gioielli — ma anche a celebrare pubblicamente l’unione tra due famiglie. Realizzati da ebanisti e artisti di grande abilità, i cassoni venivano decorati con pitture, intagli, dorature e talvolta inserti in metallo o avorio. Le scene rappresentate sulle fiancate erano spesso ispirate alla mitologia, alla storia romana, o a racconti allegorici e morali, con l’intento di esaltare le virtù coniugali, come la fedeltà, la castità e l’amore coniugale. Nelle città italiane, come Firenze, Siena e Venezia, i cassoni divennero veri e propri status symbol. Famiglie potenti come i Medici o gli Strozzi li commissionavano ad artisti affermati. In alcuni casi, la pittura dei pannelli veniva eseguita separatamente e poi applicata alla struttura lignea. Oltre alla loro valenza artistica, i cassoni riflettevano le dinamiche sociali e culturali del tempo. Il matrimonio, nel Rinascimento, non era solo un legame affettivo, ma un importante strumento di alleanza politica ed economica. Il cassone nuziale, esibito durante il corteo nuziale e poi collocato nella casa coniugale, diventava il simbolo materiale della nuova unione e della dote portata dalla sposa. Il cassone nuziale fu in uso soprattutto in Italia dal XIV al XVII secolo, tant'è che anche all'estero viene comunque chiamato col nome italiano e non ha un suo termine in lingua. Come contenitore di vestiti compare ad esempio sullo sfondo della Venere di Urbino di Tiziano Vecellio. Veniva generalmente collocato nelle camere da letto, e spesso conteneva il corredo della sposa, per cui si parla di veri e propri cassoni nuziali che venivano realizzati in occasioni dei matrimoni, spesso decorati dagli stemmi delle famiglie degli sposi. Dotato di maniglie, era letteralmente trasportato il giorno delle nozze dalla casa della sposa a quella del marito, e rappresentava quindi sia il bagaglio che essa portava con sé, sia la dote con cui accresceva il casato del consorte. Cassoni erano dati inoltre alle ragazze di buona famiglia che entravano in convento. L'importanza del cassone è legata alla frequente presenza di decorazioni dipinte, scolpite, modellate in pastiglia o intarsiate, che ne facevano pezzi di assoluto pregio nel mobilio soprattutto rinascimentale. Botteghe apposite si occupavano della realizzazione e decorazione dei cassoni: nel Quattrocento a Firenze ad esempio erano molto attive quella dello Scheggia, fratello di Masaccio, o quella di Apollonio Giovanni, nell'orbita di Paolo Uccello. Della decorazione di cassoni si occuparono occasionalmente grandi artisti, come Donatello, Andrea Mantegna (per il cassone nuziale di Paola Gonzaga), Filippino Lippi, Francesco di Giorgio Martini, il Beccafumi e naturalmente, come per i superstiti pannelli con le Storie di Nastagio degli Onesti, Botticelli. Nel XVI secolo divenne sempre più un mobile di rappresentanza, ispirandosi nella forma dei più elaborati sarcofagi antichi, o arricchendosi di decorazioni ad altorilievo.
La caccia infernale nella pineta di Classe

Sandro Botticelli, primo pannello per il cassone con le Storie di Nastagio degli Onesti, 1483, tempera su tavola, 83×138 cm, Museo del Prado, Madrid.
Il primo episodio della serie è ambientato nella pineta attorno a Ravenna e mostra il protagonista, Nastagio, che dopo aver abbandonato la città, deluso dalla sua passione amorosa non corrisposta, vaga solo e addolorato finché non si imbatte in una donna inseguita da un cavaliere e dai suoi cani che la azzannano. Nonostante cerchi di soccorrerla e difenderla, non riesce ad essere di aiuto. Si scoprirà, poi, che i due sono fantasmi e che il cavaliere è l'avo di Nastagio, Guido. A sinistra, è rappresentata la scena precedente sul piano temporale: Nastagio, in pantaloni rossi è rappresentato mentre alcuni amici gli consigliano di andarsene dalla città; poi, in primo piano, è sempre lui a vagare per la foresta, riapparendo poco dopo mentre tenta di scacciare con un bastone i cani che cercano di azzannare la donna seminuda, inseguita da un impetuoso cavaliere, armato di spada e corazza dorata. Il dipinto rappresenta dunque due scene contemporanee, per questo il protagonista appare tre volte, rappresentato in tre distinte figure. Se l'ideazione è certamente dovuta al Botticelli, l'esecuzione venne in parte delegata ai suoi assistenti di bottega, in particolare gli studiosi hanno riconosciuto la mano di Bartolomeo di Giovanni per le prime tre scene e di Jacopo del Sellaio, per l'ultima.
L'ambientazione della scena risulta particolarmente gradevole, facilitata forse anche da questa sorta di unità temporale e spaziale. I colori sono tersi e l'ambientazione naturale è misuratamente controllata e ammantata di grazia. Gli alberi dagli alti fusti verticali creano una sorta di griglia con il paesaggio marittimo a svolgimento orizzontale sullo sfondo, con un notevole sfondamento in profondità. La drammaticità convive con l'eleganza formale delle slanciate figurine, con movenze aggraziate di uomini e animali, in una magica sospensione tra favola e realtà e una percezione raffinatamente onirica. Gli ambienti risultano dunque armoniosi e ben bilanciati: il paesaggio e l'attitudine dei personaggi sono “misuratamente controllati”, grazia, armonia ed equilibrio compositivo tra figura umana e natura, sono le parole chiavi di questo episodio.
Il supplizzio che consuma sotto i nostri occhi e quelli di Nastagio

Sandro Botticelli, secondo pannello per il cassone con le Storie di Nastagio degli Onesti, 1483, tempera su tavola, 82×138 cm, Museo del Prado, Madrid.
Esattamente come il primo, anche il secondo episodio è ambientato a Ravenna e mostra Nastagio che, dopo aver assistito all'apparizione della donna sbranata da cani e inseguita da un cavaliere armato, fugge spaventato e inorridito. Mentre il cavaliere termina il suo assassinio squarciando il corpo della donna sulla schiena, con l'intento di strapparle il cuore per darlo in pasto ai cani, sullo sfondo il supplizio inizia a ripetersi. Si tratta di un'apparizione di anime dell'Inferno: il cavaliere avo di Nastagio, Guido degli Anastagi, suicidatosi dopo essere stato respinto dalla donna che amava, è stato condannato, insieme alla sua amata morta impenitente della sofferenza procuratagli, a riapparire ogni venerdì nello stesso luogo per tanti anni quanti erano stati i mesi in cui la donna ne aveva deriso il sentimento. Ad ogni apparizione, corrispondeva una nuova uccisione, il supplizio si ripeteva continuamente. Da sinistra si vedono alcuni cervi che si abbeverano a una fonte, poi Nastagio che si volta con le braccia alzate dallo spavento, mentre al centro avviene il supplizio, con sullo sfondo il riavvio dell'inseguimento; a destra sta il cavallo in attesa, mentre all'estremità, dove possiamo cogliere anche un cervo nello sfondo, sono collocati i due cani da caccia che azzannano con violenta bramosia il cuore della donna. La scena è caratterizzata da una spiccata vena narrativa, con ancora una volta, come nel primo pannello, la rappresentazione di due scene contemporanee che richiese lo sdoppiamento del personaggio di Nastagio.
Il banchetto e la svolta amorosa

Sandro Botticelli, terzo pannello per il cassone con le Storie di Nastagio degli Onesti, 1483, tempera su tavola, 83×142 cm, Museo del Prado, Madrid.
La terza scena del ciclo dedicato alla Storia di Nastagio degli Onesti ospitata un banchetto: sullo sfondo di un incannicciato adorno sul bordo superiore da un festone di frutta e foglie su cui si trovano, da sinistra, gli stemmi Pucci, Medici e Pucci-Bini. All'improvviso irrompe la fanciulla sbranata dai cani inseguita dal cavaliere con la spada e la corazza dorata, che gettano nel panico i commensali che tentano di fuggire. Le donne sulla sinistra in particolare scattano in piedi così improvvisamente da rovesciare tutte le vivande, nonostante Nastagio, girato di spalle in primo piano, stia cercando di rassicurare gli astanti. Un musico fa per tirare i tamburi addosso ai cani, mentre un altro ha abbandonato il proprio liuto sulla tavola. In seguito il cavaliere, ovvero il fantasma dell'avo di Nastagio, Guido, racconterà alla folla la sua triste e incredibile vicenda, causata dal suo suicidio per amore e dal mancato pentimento della donna che non corrispose i suoi sentimenti, la quale ogni venerdì è uccisa col cuore dato in pasto ai cani, per poi riapparire e ripetere la disperata fuga. A quelle parole la donna amata da Nastagio si pente di aver rifiutato il suo amore e, vedendo finalmente per la prima volta i suoi modi gentili, decide di sposarlo, come è raffigurato a destra, dove presso alcune tende si vede la riconciliazione tra Nastagio e la donna. Particolarmente degni di nota sono i dettagli con cui sono resi gli oggetti quotidiani — elementi di mobilio, stoviglie e vestiti, che rendono questo episodio dedicato al banchetto, motivo di notevole interesse storico e documentario.
L'ultimo pannello: l'unico rimasto in Italia
L'ultimo episodio è maestosamente ambientato sotto una serie di archi di trionfo, dove ha sede il banchetto di nozze tra Nastagio e la figlia di Paolo Traversari. Più che la vena narrativa, in questo episodio preme all'autore di rappresentare con sfarzo la celebrazione della ricca borghesia fiorentina, ponendo l'accento sulle preziose stoviglie da parata poste sul tavolino al centro, sull'abbondanza delle vivande portate da eleganti servitori, sull'eleganza delle vesti, sullo sfarzo dell'architettura. Lo sfondo mostra infatti una sorta di loggia aperta sul paesaggio, con pilastri di pietra scura dai capitelli dorati su cui si impostano gli archi. Al centro dei pilastri, nei portafiaccola, troviamo rami di mirto, simbolo dell'amore, mentre più in alto campeggiano, da sinistra, gli stemmi Pucci, Medici e Pucci-Bini. Più arretrato si trova un vero e proprio arco di trionfo all'antica con triplo fornice e bassorilievi sull'attico, ispirato a quelli visti a Roma da Botticelli nel suo recente viaggio per affrescare alcune scene della Cappella Sistina. Gli archi di trionfo caratterizzano spazialmente la scena come delle quinte teatrali, svolgendo la stessa funzione che nelle prime scene ricopriva la schiera di alberi.
Perché questo ciclo è così importante
Alcune caratteristiche fondamentali di questo ciclo pittorico le abbiamo già delineate nel corso della nostra narrazione, ma vale forse la pena riassumerle e schematizzarle. Primo aspetto più innovativo e importante del ciclo è l’uso della narrazione continua: in ogni pannello, più momenti della storia si susseguono nello stesso spazio, con il protagonista Nastagio raffigurato più volte nella stessa scena. Questo tipo di narrazione, già in uso nell’arte medievale specialmente in quella grottesca, viene ripresa e rielaborata da Botticelli in chiave più fluida e scenografica. Il ciclo ebbe grande impatto sulla pittura narrativa rinascimentale, influenzando artisti come Ghirlandaio, Benozzo Gozzoli e i decoratori delle camere nuziali fiorentine e ferraresi. La narrazione a episodi in uno spazio unitario diventò un modello imprescindibile nel racconto pittorico del Quattrocento.
Il ciclo è anche un delizioso e precoce esempio di illustrazione pittorica di un’opera letteraria umanistica: Botticelli e la sua bottega riescono a tradurre un racconto complesso e carico di tensione morale in immagini chiare, eleganti e simboliche, aprendo la strada a un dialogo più strutturato tra arti visive e letteratura nel Rinascimento. Successivamente, altri pittori — Pinturicchio, Perugino fra tutti — si cimentarono nella traduzione visiva di testi letterari e mitologici. Anche le illustrazioni del Decameron in manoscritti miniati e a stampa subirono un forte influsso botticelliano. Dal punto di vista iconografico e decorativo, il ciclo riflette un'estetica pensata per la camera nuziale, con un forte messaggio morale: la punizione della donna crudele e il premio dell’amore corrisposto. La scelta del soggetto e il suo trattamento visivo diventeranno paradigmatici per molti cassoni e spalliere rinascimentali, in cui la funzione educativa si unisce alla celebrazione dell’unione matrimoniale. La simbologia morale del ciclo di Nastagio ispirò una lunga tradizione di dipinti "di camera" volti a istruire la sposa o celebrare le virtù familiari. L’impostazione architettonica e il gusto per i dettagli quotidiani (come le stoviglie, i vestiti, le architetture domestiche) si ritroveranno in numerose opere decorative fino al primo Cinquecento. Altra peculiarità del ciclo è il gusto per il macabro e la definizione di una nuova estetica: la scena centrale della novella e della decorazione, ovvero la donna inseguita e sbranata nel bosco, introduce elementi fantastici e crudeli, ma rappresentati con incredibile grazia e misura. Questa tensione tra bellezza formale e contenuto drammatico influenzò artisti interessati a tematiche allegoriche o morali, e può essere riconosciuta come il vero precedente del gusto manierista per il contrasto e l’ambiguità. Quella fusione tra elegante stilizzazione e racconto crudele anticipa infatti soluzioni che si ritroveranno nell’arte manierista, specialmente in opere di Pontormo e Rosso Fiorentino.
In copertina: dettaglio del primo pannello del ciclo di Nastagio degli Onesti.
Suggeriti
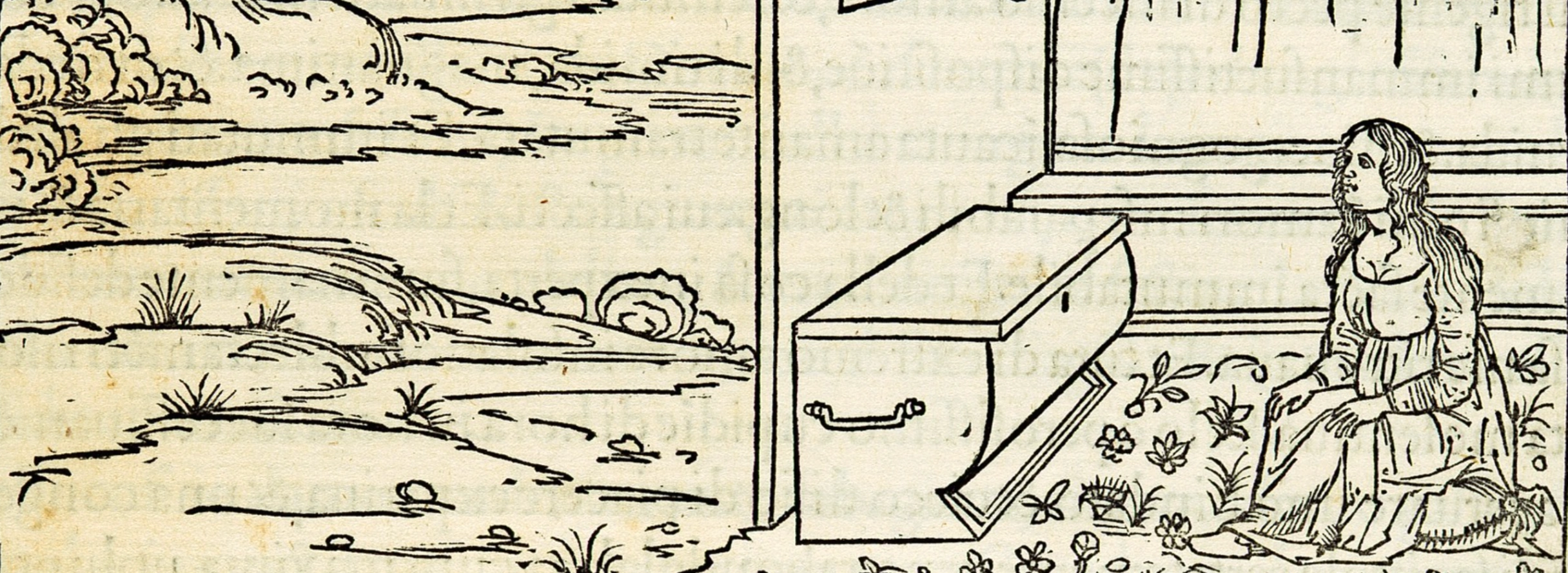
FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NATIVITÀ MISTICA DI SANDRO BOTTICELLI

LEONARDO DA VINCI: IL GENIO CHE INVENTÒ IL DESIGN DEL FUTURO

PIETRO TORRIGIANO: L'ACERRIMO RIVALE DI MICHELANGELO CHE CON LA SUA ARTE CONQUISTÒ INGHILTERRA E SPAGNA

L'INASPETTATA CONNESSIONE TRA BEATO ANGELICO, LE SUE PITTURE RELIGIOSE E IL MONDO DELLA MODA

QUANDO LA MODA ITALIANA HA SCELTO COME SIMBOLO GLI ANGIOLETTI DI RAFFAELLO SANZIO
